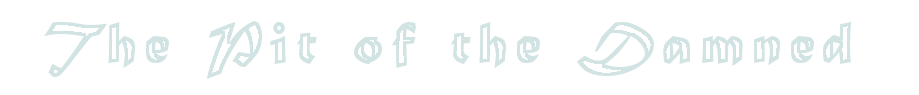|
| #PER CHI AMA: Power Progressive, Dream Theater, Evergrey |
Uno scenario post-apocalittico si delinea innanzi allo sguardo. In copertina sembrano rimaste solo le vestigia di un mondo distrutto e abbandonato dall'umanità. Uomo capace sia di questo che di creare un simbolico album, come gli Abstraction han saputo fare con il loro eloquente 'End of Hope'. Il singolo "Wolf" mette a confronto l'uomo con la bestia, la quale è molto meno crudele con i suoi simili di quanto esso non lo sia con i propri. Una città corrotta in cui l'uomo divora l'uomo con la voracità di un lupo, una foresta nella quale la bestia accoglie l'umano che sappia ascoltare il suo libero canto. La chitarra acustica di Kiril Yanev si fa portavoce del tema di una canzone tradizionale bulgara, mentre la leggenda narrata sembra scaturire da antiche storie mai obliate. Una breve sinfonia orchestrale introduce questo pezzo, che si distacca molto stilisticamente dal resto dell'album, richiamando alla mente band quali gli ultimi Wintersun e Blind Guardian. Ma resta un'impressione superficiale, dato che il sound appare più pulito e asciutto e l'organico più minimale, innestando di fatto la band in un genere che sta a metà strada tra il power e il progressive metal. Il pezzo ruota attorno al tema esposto dalla voce narrante di Mladen Medarov nelle sezioni acustiche, contrapposto ai fraseggi di chitarra elettrica di Pavel Serafimov armonizzati dall'altra di Danail Karjilov nelle sezioni strumentali. Interessante è il gioco contrappuntistico tra flauto e cembalo sul tema acustico. A metà brano un coro interpreta la parte del branco di lupi sulla base a marcia già esposta nella strofa precedente, prima dell'arrivo di un virtuosistico assolo di chitarra che anticipa la ripresa, terminante a sua volta con un finale strumentale dalla ritmica serrata e delle code. Allo scattare del secondo brano l'ascoltatore è catapultato negli anni ottanta, con un incipit che sembra un tributo alla celebre "Two Minutes to Midnight" dei Maiden. "Wondering" si presenta come un pezzo dal testo contemplativo, nel quale è manifesta solo in seguito l'amarezza lasciata da un incolmabile vuoto. Una celata rabbia non sfogata ma interpretata dalla musica con una struttura a blocchi e poi triplette nei chorus con tastiere nello sfondo e una sezione di cori nella parte centrale e finale che rappresenta, a causa dell'incerta intonazione, il vero neo del pezzo. Un brano che a tratti ricorda i Bon Jovi degli esordi, in particolare nelle vocals, nel quale viene inserita una sezione strumentale prog che riprende temi ritmici caratterizzanti lo stile dei Dream Theater, complici però un forzato connubio di stili, un cantato non abbastanza sostenuto ed esplosivo e un songwriting non in linea con le atmosfere musicali, si tratta di un capitolo dell'album poco riuscito. La scacchiera è pronta, le pedine di "The Game" cominciano a muoversi. Le prime a spostarsi sono tre e corrispondono ad altrettante stanze nelle lyrics, le quali esplorano sia il punto di vista dei vincitori che dei vinti, nell'eterna lotta tra chi ha potere e chi non ce l'ha. La terza stanza è un chorus, nel quale è interessante lo scambio tra la voce e un contrastante cembalo synth. Questa struttura ripetuta due volte cede il posto, dopo un intermezzo di cembalo, a uno strumentale che ha molti punti in comune con le sonorità e le ritmiche degli Iron ma strizza l'occhio anche al prog nell'uso di controtempi e poliritmie. Il pezzo si chiude dopo un significativo "GAME OVER" che riporta trama e musica all'inevitabile fato. "The Last Man On Earth" è forse una delle immagini più belle ed evocative dell'opera. E proprio di opera metal si tratta, l'intro riporta potenti alla mente le suggestioni dei Rhapsody of Fire. Chitarra acustica e flauto precedono un coro, questa volta dal sapore epico. I neoclassici fraseggi di chitarra solista strizzano l'occhio a Luca Turilli. Le vocals molto dirette e ruvide qui non disturbano perché ogni riff e ogni sezione strumentale risulta perfettamente incastonata, per un pezzo che sicuramente brilla in quest'album come un gioiello. Samples tratte dalla serie tv 'Kingdom Hospital' dialogano attivamente con la musica in questo strumentale "Piece of Life". Non è necessario dilungarsi sulle prime sperimentazione in tal senso da parte di mostri sacri come i Pink Floyd, nei quali musica e suoni diventavano un tutt'uno; precisando che uno tra i primi brani a introdurre registrazioni vocali parlate e attive nella musica fu "Space-Dye Vest" (Dream Theater, Awake, 1994). "Shattered Pieces" incarna appieno nelle tematiche il concetto espresso dal titolo dell'album. Difficile non pensare a band quali gli Evergrey ascoltandone le idee musicali, dove ad atmosferiche linee di piano e archi son contrapposti potenti e decisi blocchi ritmici. E così i pezzi del puzzle che compongono i sogni vengono sparpagliati a ogni scarica strumentale e la voce si fa portante nell'esporre questa rassegnazione, in modo talvolta troppo monocorde. Ottima la sezione solistica di chitarra centrale che anticipa un parlato accompagnato dal piano, punto di luce che trafigge i nembi di un brano vagamente monodico. Le lyrics di "The Righteous Path" abbandonano sentieri piani e sgombri per seguire vie più anguste e simboliche, cosa che finora mancava nel songwriting dalla band, in cui la bellezza delle tematiche veniva troppo spesso impoverita da un'espressione troppo diretta e prevedibile. Inaspettato è il pizzicato introduttivo e il ritmo ad accentuazione irregolare che ne consegue, per uno dei pezzi più progressivi dell'opera e uno dei più caratterizzanti. Spiazzano i ritmi a singhiozzo di Antonio Velkov, essenziale e magistrale dietro le pelli della batteria da inizio a fine album. Stupisce il primo vero intervento solistico di Ivaylo Rashev al basso, che confeziona un intermezzo con imitazione a due voci alle estremità del campo uditivo e un giro ammaliante su una base calma e suadente che ricorda un suo gemello marchiato John Myung nella multiforme "Breaking All Illusions". Questi a loro volta racchiudono una parte vocale doppiata una una voce parlata distorta, che allarga il campo dei narratori del testo. Ma le sorprese non finiscono, alternati al riff tematico più volte esposto in modo ubriacante, vi sono un assolo di tastiera e un altro intermezzo dal sapore contrappuntistico e questo contrasto da equilibrio compositivo al tutto. Ora è il turno di uno dei capitoli concettualmente chiave del concept, "Requiem for a Dead Planet". Poche parole cariche di significato trasportano attraverso futuro e passato, attraverso una musica graffiante, introdotta da acustica e samples create con autentiche registrazioni della NASA. L'inizio è una grande rullata, che si fa portavoce dei singulti di un pianeta morente, le vocals sono dirette ma questa volta supportate da un coro di milioni di voci che l'atmosfera creata dalle tematiche fa credere di percepire, lamenti di esseri morenti. Mai più espressivo è stato un silenzio, quello strumentale, che lascia il posto nei suoi vuoti a una voce, carpita da trasmissioni radio distorte, dialogandovi attivamente. Questo e molto ancora in un brano che crea un alone lunare profetico, sublime come l'immagine sibillina della tragica sorte del mondo nelle ultime pagine de 'La Coscienza di Zeno'. Quando la narrazione musicale e tematica sembra arrivata al culmine della tensione ecco "Same Again", stelo d'erba accarezzato dal vento, affacciato a un precipizio. L'unica ballad dell'opera acquista ancor maggior forza, nel suo esser conclusiva e solitaria. La voce ruvida e diretta del vocalist acquista qui una commovente morbidezza e assieme alla prima traccia costituisce una delle prestazioni migliori di Medarov, che qui duetta con una bella base di piano pad firmata Serafimov, che si apre assieme alla sua voce ad armonie vaste e irraggiungibili da voce e piano presi singolarmente. Un testo d'amore, distanza e separazione, ispirato al film di Danny DeVito 'The War of the Roses' da cui sono estrapolati dialoghi a creare una samples che accompagna tutto il brano. Un episodio che fa pensare, perchè il contesto rende questo brano speciale e in un certo senso dal taglio inaspettato. Gli Abstraction hanno dimostrato in questo lavoro grande maturità compositiva, una non comune capacità strumentale e una sensibilità viva e lungimirante nelle tematiche. Davvero notevole il lavoro di mix e master, come la qualità della registrazione e la pulizia di esecuzione e sound nella parte strumentale. La sezione vocale si presenta spesso non all'altezza di quella strumentale, in intonazione e impatto d'insieme per quanto riguarda i cori; in sostegno ed espressione per quanto riguarda la solista, che suona spesso troppo di gola e poco agile nel muoversi nel suo registro. La band deve ancora trovare un proprio stile, in quanto le varie e variegate idee musicali risentono spesso di troppo manifeste influenze di altri gruppi. Ciò ha però reso possibile un album davvero ricco di idee e pure ben sviluppate. Anche il songwriting possiede questa varietà, tanto da dover precisare come impropria la definizione univoca di concept per quest'album. Simbolico ed evocativo è l'artwork firmato da Ivan Maslev. Non è un caso forse che il nome "Ninfa" che appare sulla nave riporti alla mente il mito greco di Dafne, trasformata in alloro per sfuggire alle lusinghe amorose del dio Apollo. E in albero è tramutata anche questa barca volante, attraccata a un molo fantasma al di sopra del volo dei gabbiani, tema che rimanda alla moderna arca di Noé di cui tratta "Requiem for a Dead Planet", la cui rotta è lo spazio, la conquista di nuove terre da consumare e l'inevitabile fine dell'umanità, fino a un ultimo e definitivo apocalisse. (Marco Pedrali)
(Self - 2014)
Voto: 80