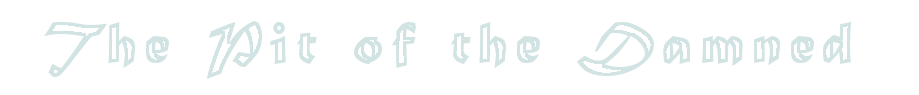|
| #PER CHI AMA: Post Metal, Isis, Pelican, Cult of Luna |
Il trono degli Isis è vacante da un pezzo e si cerca in giro nel mondo qualcuno che abbia la credibilità per potervisi sedere. A migliaia i candidati, un po' come nella leggenda di Re Artù che ottenne il trono estraendo la spada nella roccia. Quest'oggi a provarci sono i canadesi Sarin e il loro album 'Burial Dreams', che oltre a presentarsi graficamente con un packaging lussuoso, con la opening track dimostrano di saperci già fare. "As Well as the Body" è infatti la classica traccia "isisiana" (chi ha detto 'Panopticon'?) dalle roboanti ritmiche accompagnate da vocals che potrebbero essere tranquillamente quelle di Aaron Turner, e poi da suggestive e dilatate atmosfere acustiche. Il sonoro della band dell'Ontario mi si infila immediatamente sotto la pelle e non posso far altro che godere dei saliscendi musicali dei nostri, dei riverberati chiari scuri che luccicano e si spengono nel buio della notte, in un climax ascendente da brividi. La prima traccia è quasi da 10. Con "An Empty Place" facciamo una pausa di una manciata di minuti che ci introduce alla più sognante "Monograph", song mid-tempo dal piglio malinconico, che ha comunque il pregio di offrire momenti di flusso emozionale grazie alle sue lunghe parti ambient interrotte da quei muri ritmici che sembrano sovrapporre una, due o forse dieci chitarre. Un'altra breve pausa ed è il momento della più claustrofobica "-", ossessiva e magmatica nel suo incedere drone. Ancora un intermezzo dove a comparire è una voce femminile (di tal Angela Deveros) prima della conclusiva "Reverse Mirror", in cui la brava vocalist apre il brano e si affianca allo screaming corrosivo di Wilson, in una song sinistra davvero ficcante. Non so se i Sarin saranno in grado di estrarre la spada e sedersi su quel trono, quel che è certo è che io tiferò per loro. (Francesco Scarci)
(Self - 2014)
Voto: 80
https://www.facebook.com/sarinofficial
Voto: 80
https://www.facebook.com/sarinofficial