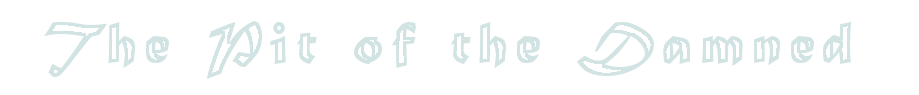|
| #PER CHI AMA: Stoner, Sludge, Doom, Post-rock |
Se vi chiedessi di pensare all’ultimo strumento che vi aspettereste di trovare nella formazione stabile di una band stoner-doom, credo ci siano buone probabilità che la risposta possa essere “il flauto”. Ecco quindi un primo motivo di interesse che spinge all’approccio con questo combo siberiano, al loro secondo lavoro dopo, come si legge nelle note disponibili in rete, una longa pausa che ha portato ad un radicale cambiamento nel suono, partito da basi di doom/death melodico, per approdare al curioso e originale ibrido racchiuso in questo cd. Già la copertina ha un che di allucinatorio, con un astronauta – tributo nemmeno troppo velato ai grandissimi Sleep – intento a prendersi una solenne sbornia seduto a un bancone di cui voi siete il barista, che sembra sul punto di raccontarvi la propria vita. Quello che si ascolta nel corso dei quattro lunghi brani che compongono il lavoro è un mix inaudito di classici riffoni stoner-doom (l’opener “Routine of Life”), parentesi bucoliche e quasi trance, dominate dall’effetto straniante del flauto (“Dirty Game”), e digressioni post rock lente e circolari (“Dregs”). A complicare le cose ci si mette una cantato growl ultratombale, tenuto però ben sepolto nel missaggio, tanto che l’impressione finale è quella di avere a che fare con un disco strumentale. Detto così mi rendo conto che potrebbe sembrare un pasticciaccio, ma ben presto vi sorprenderete ad abbandonarvi al flusso ipnotico che sgorga dai vostri speaker, trasportati da una corrente lisergica e multiforme. Rimane da dire di una bonus track (“Cause Follows Effect”), anch’essa molto lunga, che si distacca dall’atmosfera del resto del disco (e risulta anche meno interessante, almeno per i miei gusti) rimanendo ancorata a stilemi doom/death più classici, nella quale il cantato cavernoso è affiancato da suggestive voci femminili e tappeti tastieristici. In definitiva, quindi, un lavoro molto originale, nel quale forse è insito il pericolo che l’effetto sorpresa si esaurisca in fretta, costringendo la band russa ad aggiustare nuovamente il tiro in futuro. Ma per il momento va bene così. (Mauro Catena)
(Solitude Productions, 2013)
Voto: 70
http://evokethylords.bandcamp.com/
Voto: 70
http://evokethylords.bandcamp.com/