 |
| #PER CHI AMA: Black, Death, Doom, Folk |
Milwaukee, Wisconsin: una nuova scoperta per il sottoscritto, gli Arbor e il loro debut album, “The Plutonian Shore”. Apre le danze la tiepida strumentale title track, poi ecco “Trees” a spianarmi la visione del mondo di questa giovane band statunitense. Di primo acchito, ho pensato agli Agalloch e a tutto il movimento del Cascadian Black Metal, che si sta lentamente sviluppando negli U.S. e sta prendendo piano piano piede anche in Europa. Poi ho dovuto correggere il tiro e cercare di capire la reale proposta del quintetto, perché il sound di “The Plutonian Shores” ha qualcosa di innovativo, mischiando nel suo avanzare, sonorità death, doom, folkish e black, che mi hanno disorientato non poco, ed allo stesso tempo entusiasmato. Non so se sia colpa delle voci, che passano dal growl allo screaming, facendo sosta anche in territori clean o proponendo improbabili chorus puliti, fatto sta che gli Arbor stuzzicano, con il loro sound, la mia immaginazione. L’attacco di “A Great Leap In the Dark” è folle: sembra dapprima swedish death, corredato da voci black, ma in un battibaleno la traccia assume il tono di una ninna nanna, per poi lanciarsi nuovamente in un contesto black death con un sound violento, potente ed affilato, alternandosi con brillanti aperture acustiche dal sapore folk. Spero, non soffriate di vertigini, perché tra sali e scendi pericolosi, qui si rischia peggio che andare sulle montagne russe. “Grey Waters” conferma il trend dell’album, con lo sconquassamento di un sound robusto che subisce le incursioni notturne di parti atmosferiche, che interrompono la tenacità dei nostri. Arrivo al termine del brano e faccio fatica a contare i cambi di tempo che la song ha vissuto, soprattutto in termini vocali, con la performance del vocalist che arriva a sfiorare addirittura anche gli Skyclad. Non è semplice, ve lo assicuro, però si sa che i compiti arditi, sono quelli più interessanti. Proseguo nel mio ascolto. Il suono della pioggia, e le chitarre malinconiche mi fanno pensare quasi ad una semi-ballad, ma mai calare il livello di guardia con gli Arbor: una batteria al limite del tribale si impossessa come un demone, della ritmica e insieme alle sei corde di Joe e Zak, ci invitano a danze folkloristiche sotto le stelle. La cosa meravigliosa è che non sono ancora riuscito ad identificare una band a cui ricondurre il sound dei nostri, e questo è quasi un miracolo. Ci provo con “Begotten From Mother Earth” ma fallisco miseramente: forse è il suono etnico della batteria allora che mi rapisce i pensieri e mi impedisce confronti. Non saprei, perché anche le chitarre in effetti non seguono assolutamente schemi precisi come il black, il death o quel diavolo che preferite, impongono. Gli Arbor fanno quello che gli pare e piace e, per una volta mi trovo nella situazione, di non riuscire a prevedere che cosa venga dopo una ritmica, un arpeggio o una vomitata nel microfono. L’anarchia regna sovrana nel sound degli Arbor, anche nella strumentale “Pillars” e confermo che ciò non può essere che un bene. Non esagero col voto semplicemente per due semplici motivi: la registrazione non è troppo convincente cosi come pure la prova vocale, in stile pulito di Ted, che preferisco in formato estremo. Tuttavia, se siete degli amati di sonorità progressive, in chiave estrema, beh gli Arbor fanno decisamente al caso vostro. L’obbligo non è un consiglio… (Francesco Scarci)
(Self)
Voto: 75
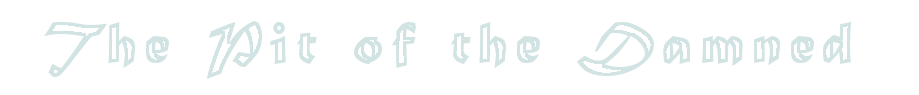









.jpg)
