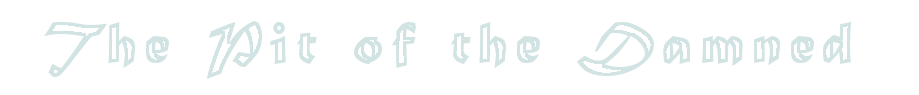|
| #PER CHI AMA: Post Rock/Shoegaze, Tame Impala, Porcupine Tree |
Le one-man band sono pericolose: innanzitutto perché, per fare un bel lavoro, devi essere sostanzialmente un genio. E poi perché in qualche modo il tuo strumento preferito rischia sempre di sovrastare gli altri. È inconscio, credo. Nel caso del francese Sebastian, mente e cuore dietro il progetto Amphetamin, lo strumento prediletto è la voce: emozionale, sospirata, melodica, capace di creare belle atmosfere. Le linee vocali sono ricche di falsetti – che personalmente amo poco, ma tant’è – e mi ricordano qua e là nello stile, Steven Wilson, HIM e forse qualcosa di James Blake. Intendiamoci: Sebastian ha una voce pulita, precisa e capace di suscitare forti sensazioni. Ma la composizione e la produzione stessa del disco la premiano fin troppo: 'A Flood Of Strange Sensations' è un lavoro fortemente incentrato sulla voce. Si salva forse la chitarra (splendido l’assolo in “Favourite Doll” o la progressione di accordi in “Endless Nights”), mentre batteria, basso e synth spariscono in un lago di noia e pattern banalissimi. Musicalmente, è un disco che definirei post-rock/shoegaze nel solco di Tame Impala e Porcupine Tree, pur avendo qualcosa di prog, una forte attenzione all’atmosfera generale e anche certe interessanti venature esotiche (“Stranger On An Island”). Non mancano ritmiche serrate e distorte (“The Threshold”), ma in generale la predilezione di Amphetamin/Sebastian è per la melodia, l’arpeggio indovinato, i violini a tappetone, il mid-tempo in quattro quarti (“Neverland”). Applaudo il tentativo dell’autore di costruire un album che si lascia ascoltare, scorre piacevole pur senza stupire; e di costruirlo interamente da solo – dalla scrittura alla registrazione, fino all’autoproduzione. Ciononostante, le pur belle melodie vocali di in 'A Flood Of Strange Sensations' nascondono una composizione strumentale solo mediocre. Il risultato è un bell’esercizio vocale non sufficientemente supportato musicalmente: ma sarei curioso di ascoltare Sebastian inserito a tutti gli effetti in un gruppo “vero” – lì sì che potrebbe regalare grandi sorprese. (Stefano Torregrossa)
(Self- 2016)
Voto: 65
https://amphetamin.bandcamp.com/
Voto: 65
https://amphetamin.bandcamp.com/