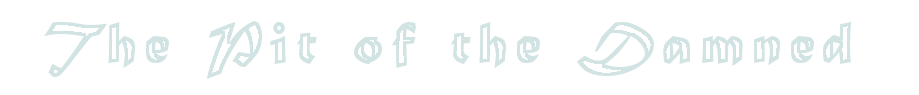|
| #PER CHI AMA: Black Sinfonico |
“Marley, prima di tutto, era morto.” “Marley, prima di tutto, era morto.” “Marley, prima di tutto, era morto.” È questa l’insolita litania che avverto ripetersi, amplificarsi tra le solide, elastiche pareti della mia testa. Parole che rimbalzano e sinuose riverberano, scolpiscono arcuate, altissime navate nella gotica cattedrale della mia mente. Crollo estasiato, mi piego dinanzi al mio io più profondo, ma non ne soffro, al contrario ne godo: mi regalo un piacere tra i più sublimi. Mai nulla di sacro, nelle mie, di cattedrali. Era mio obiettivo trasmettere, a te lettore che stai leggendo, quello che sento, quello che avverto avventurandomi in questa novella, “A Christmas Carol”, concept basato sull’omonimo romanzo breve, partorito dal genio di Charles Dickens e rivisitato per noi dagli italianissimi Riul Doamnei, band gigante rossa, grondante sangue, materia oscura che occupa lo spazio vuoto di quel vasto universo qual è il symphonic black metal. Genere vasto, oserei dire oceanografico. Mi sovvengono quei famosi versi di Dante “Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita.” Ma questo non è il caso, la via non è per niente smarrita, anzi, il concept nel quale i nostri tricolori patrioti ci vogliono inebriare è ialino, adamantino. Mi concedo giusto due parole sulla trama della novella per incuriosire quei lettori che non fossero avvezzi all’opera Dickensiana: il ricco quanto avaro protagonista, tal Ebenezer Scrooge, viene visitato da tre spiriti nel bel mezzo della notte di Natale nella Londra del 1843: il Natale Passato, il Natale Presente ed il Natale Futuro. A seguito di questi incontri, il comportamento di Scrooge cambierà radicalmente. Abituato come sono, a vederli sul palco con i loro “scherzi da prete” che devo dire, dentro di me, ho sempre molto apprezzato (solo chi segue anche dal vivo questa band capirà codeste mie parole), non hanno mancato, questa volta con inedite ed evanescenti sembianze da spettri, di stupire ancora il pubblico, come sempre entusiasta. Non mancate assolutamente quindi di vedere questa interessante, nostrana formazione esibirsi anche dal vivo: è questa infatti una band sempre molto attiva, che batte numerosissimi palchi in patria e non solo, dalla presenza scenica d’effetto, travolgente, con una certosina meticolosità nella cura del dettaglio in particolare dal punto di vista vestiario, sempre molto creativo e d’impatto. Pur essendo calcificati come unica traccia, i testi di questa spina dorsale sostengono a meraviglia uno scheletro articolato su cinque vertebre talvolta triplicemente fratturate tramite “subtitoli”. Sarete accompagnati non solo da musica ma anche da campioni ambientali durante questa sonora novella: un amalgama di testi, musiche e suoni, trasmetterà forti emozioni percepibili dai cinque sensi. Voglio per una volta scordarmi dell’udito, senso troppo semplice da utilizzare in campo musicale e tra l’altro da me già troppo sfruttato in certe mie precedenti infusioni metallare. Un contributo importante, questa volta, ci viene dalla vista: le vostre macule saranno certo deliziate dalle meravigliose immagini del filmato, magnificamente realizzato, che accompagna le melodie. Inutile dire, però, che anche qui il sentiero sarebbe per me troppo facile da seguire. Voglio divertirmi a seguire un percorso molto più impervio, tipo quello di Frodo verso Monte Fato: direi che la strada giusta questa volta è quella dell’olfatto. Mi divertirò interpretando l’armonia di questa riuscita opera musicale dal punto di vista olfattivo. La immaginerò come fosse un profumo. Non solo musica nella formulazione di quest’orgasmo olfattivo. La nota di testa, che si percepisce subito, ci viene dai suoni ambientali: vi aiuteranno a calarvi nel giusto stato psicofisico. Di quali volatili molecole ci stanno nebulizzando? Un canto di Natale. Una carrozza trainata da cavalli che si muove sulla pietra bagnata e resa sdrucciolevole dalla neve fresca: ne avvertirete gli zoccoli. Forse non erano zoccoli equini ma… luciferini. Passi, passi nella neve. Il vento che soffia, sibila, sferza tagliente la neve. La sposta, crea strani disegni, sigilli degni del Liber Juratus Honorii, è Eolo, Eolo che gioca col suo mefitico alito sino ad infrangerlo incazzato sugli stipiti di una logora porta. Un portale delle tenebre che si apre e si richiude scricchiolando minacciosamente alle vostre spalle. Un portale dal quale non tornerete indietro: lasciate ogni speranza o voi ch’entrate. Lì vicino sento pure un fuoco: arde. E catene, catene trascinate nell’oscurità. La nota di cuore, percepibile nelle ore che seguono la scomparsa della nota di testa, ci arriva, in questo nostro singolare percorso olfattivo, dal growling: percepisco le singolari corde vocali di Federico come intrise del sangue di vergini sacrificali. Sangue che vedo ritmicamente gocciolare sulle corde delle due chitarre della formazione. Veloci file di ordinate gocce, come formiche operaie corrono sicure e, prima di cadere nell’oblio del vuoto più nero, percorrono le corde delle chitarre in tutta la loro lunghezza. Corde che nel mio immaginario, certo evocato dalle singolari melodie, vedo montate non su chitarre ma su di una coppia di arpe. Arpe pizzicate non da semplici dita ma dai velenosi ed affilati denti aguzzi di teste di serpe montate sul capo della mitologica Idra. Ad accompagnare queste erpetologiche plettrate troviamo la sempre precisa, simmetrica ragnatela tipica della vedova nera: così vedo perpetrata la fitta tessitura delle melodie provenienti dalla tastiera. Pressioni dei tasti certo veloci come le forbici di Edward ma al tempo stesso precise, precise come mandala tibetani. A conclusione di questa mia profumata dissertazione, la nota di fondo, ultima parte del processo profumiero che contiene gli elementi persistenti, senza alcun dubbio, in questo caso, ci viene dal basso e dalla batteria: due strumenti che quando s’incontrano, in questo particolare genere musicale, come sempre non suonano ma fanno l’amore. In questo “A Christmas Carol”, ve l’assicuro, ci danno dentro di brutto. Grande e lodevole, quindi, anche la prova di basso e batteria: tamburi di certo ricavati da pelli umane provenienti da quel particolare tipo di spregevole peccatore mammifero di nero vestito si ben descritto in una precedente traccia dei Riul Doamnei, mi riferisco a “Sodoma Convent” presente in “Fatima”. Le stesse corde del basso certo hanno la stessa origine mammifera ma questa volta si tratta di budella anziché di pelli. Come noto, di un certo tipo di animale da fattoria, non si butta mai via niente... (Rudi Remelli)