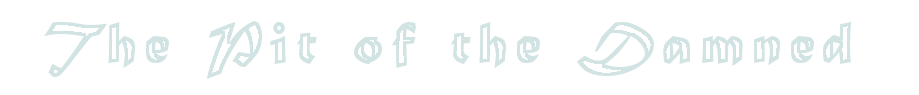|
| #PER CHI AMA: Gothic Rock, The Fields of the Nephilim |
Per questioni d’anagrafe non sono forse la persona più adatta per valutare un lavoro come “Roots and the Dust”, che rifacendosi ad un gothic-rock vecchia scuola, necessiterebbe quanto meno di un recensore più navigato di me! Tuttavia, penso non serva maturare alcuna anzianità per riconoscere una band con dei numeri e in questo senso gli Ordeal By Fire colpiscono già dal primo ascolto per la loro grinta e la loro preparazione tecnica. Non fatevi ingannare dal nome, perché non è di musicisti in erba che stiamo parlando e se negli ultimi anni avete sfogliato qualche fanzine italiana del settore saprete meglio di me che il gruppo nasce dalle ceneri dei torinesi Burning Gates, nome di culto della scena gothic-rock nostrana, che tra il 1996 e il 2002 ha rilasciato tre album: “Risvegli”, “Aurora Borealis” e “Wounds”. Ed è proprio dallo scioglimento ufficiale dei Burning Gates che il membro fondatore Michele Piccolo ha voluto ripartire, dando il via ad un nuovo cammino sotto il nome di Ordeal By Fire, assieme a Riccardo Perugini (chitarra), Fabrizio Filippi (basso) e XXX (batterista dei Right in Sight). “Roots and the Dust” è il primo passo discografico della band, un EP di ruvido e potente gothic-rock nel quale feeling e perizia esecutiva si incontrano magicamente; quattro tracce dalle tinte forti che ci accarezzano, ci percuotono... ci fanno sentire vivi! La sintonia tra i ragazzi degli Ordeal By Fire è talmente perfetta che nessuno degli strumenti riesce a prevalere sugli altri, anche se ascoltando l’ultimo brano “New Dark Age” (cover dei The Sound) risulta davvero difficile rimanere indifferenti alla prova superlativa del chitarrista Riccardo! Il cantato sottolinea invece con vigore ogni passaggio, destreggiandosi tra timbriche basse, ruggiti alla Carl McCoy e decise sferzate dalle tonalità più alte in cui l”ugola graffiante di Michele pare trovarsi più a suo agio. Forse in “Roots and the Dust” andava rifinito ancora qualcosa nella produzione ma per il resto quello degli Ordeal By Fire è un esordio più che convincente e ora rimane solo la curiosità di saggiare dal vivo questi brani che sembrano nati proprio per essere vissuti sul palco. (Roberto Alba)
(Innermost Phobia)
Voto: 75
Voto: 75