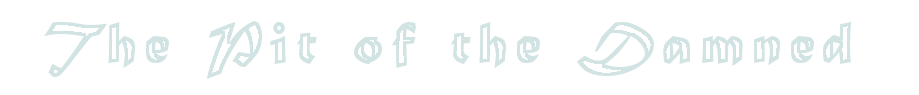|
| #PER CHI AMA: Noise Rock, My Bloody Valentine, Sonic Youth |
Musicalmente sono nato tardi e per molti anni non sono uscito dalla rassicurante galassia delle chitarre zanzarose e delle percussioni a mitraglia finché nel 2008 un amico mi consigliò di ascoltare 'Loveless' dei My Bloody Valentine e i miei preconcetti vennero spazzati via da quella marea di muri sonori. Ricordo ancora il rimpianto per aver perso gli anni dell’esplosione di noise rock, shoegaze, dream pop e post-punk, salvo poi scoprire che l’interesse per quei generi si stava rinnovando al punto da concedere una nuova giovinezza alle formazioni storiche e favorire la nascita di una schiera di epigoni. In mezzo a questa pletora di gruppi (non sempre in grado di offrire spunti memorabili) troviamo gli Entrepreneurs, formazione al debutto con l’album 'Noise & Romance', ben decisa ad uscire dalla periferia della scena alternativa: a differenza di molti colleghi infatti questo ambizioso terzetto di Copenaghen si sforza di proporre nuove sperimentazioni, pur con chiari omaggi ai pionieri del passato. È dunque la contrapposizione alla base di questo lavoro, non solo tra vecchio e nuovo, ma anche nell’alternarsi di esplosioni di rumore e distorsioni sferzanti con armonie piacevolmente pop e condite da testi romantici (da qui il titolo), contrasto reso anche in copertina dove un’intrigante ragazza è immersa in una vecchia vasca piena di liquido blu, immagine che peraltro sembra richiamare l’artwork di 'Around the Fur' dei Deftones, autori anche loro (pur in chiave più dark) di un efficace connubio tra musica estrema e melodie seducenti. Le dieci tracce che compongono l’album sono un caleidoscopio di stili diversi: si parte con i feedback a cascata e le basse stordenti di “Session 1”, una sorta di rivisitazione in chiave moderna "Only Shallow" dei MBV, per poi passare alla cavalcata psichedelica di “Say So!”, quasi isterica nei suoi continui cambi di dinamica e che ci lancia nel singolo “Joaquin”, una corsa scatenata in stile Sonic Youth, guidati dalla voce scanzonata del cantante. Le ritmiche pulsanti di “Sail Away” e gli intrecci sonici di “Be Mine” ci conducono ad “Heroine”, dove esplosioni di volume e riff pachidermici, fanno da contraltare a strofe colme di dolcezza: è l’apice del disco, in cui le diverse influenze del gruppo si fondono in perfetta armonia. I brani che seguono appaiono più crepuscolari, dando spazio al dream pop elettronico di “Ages” e alle schitarrate in stile Pavement di "Despair". In chiusura troviamo l’immancabile traccia acustica (“Morning Sun”) e la malinconica e quasi Radiohead “D Tune”, pezzi ugualmente intensi ma forse un po’ meno ispirati. Dunque, come valutare l’opera? Del buon revival per ascoltatori malinconici o una produzione matura e davvero indipendente? Gli Entrepreneurs strizzano l’occhio ai nostalgici riproponendo soluzioni le cui paternità sono evidenti, tuttavia la capacità mostrata nell’amalgamare omaggi al passato e spunti più moderni rendono 'Noise & Romance' una novità piacevole e tutt’altro che derivativa. La loro energia, abbinata ad una crescita nella stesura dei pezzi, potrebbe riservarci piacevoli soprese per il futuro. (Shadowsofthesun)
(Tambourhinoceros - 2019)
Voto: 70
https://theentrepreneurs.bandcamp.com/album/noise-romance
Voto: 70
https://theentrepreneurs.bandcamp.com/album/noise-romance